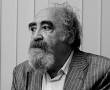Arnold Słucki

Eliasz Rajzman
Diversi anni fa il mio amico poeta, prosatore, drammaturgo, traduttore e critico letterario Marian Grześczak (1934-2010), presente nel mio blog, dedicò questo suo articolo a due poeti ebrei: Eliasz Rajzman, che scrisse in lingua yiddish, e Arnold Słucki che scrisse in polacco. Lo propongo oggi nella mia traduzione ai lettori del mio blog, con alcune poesie degli stessi autori, anch’esse nella mia versione.
La patria esterna e la patria interna del poeta
In una stradina dell’Europa centrale
ho udito il sole
e ciò accadeva nell’esilio da tutte le patrie, fedi, ideologie…
– così inizia la poesia Socrate di Arnold Słucki, scritta a Bad Gedesberg.
I poeti portano la patria in loro stessi, la prendono con loro nelle peregrinazioni temporali e spaziali, la proteggono gelosamente, si dolgono, piangono e ridono assieme ad essa. Se il poeta vede bianco, anche la parola biancore il più delle volte germoglia nei suoi versi, possiamo essere certi che i suoi occhi, i suoi occhi dell’infanzia, si sono nutriti del paesaggio coperto di neve. Se il poeta vede luminoso, anche il gioco di luci e ombre s’inserisce nei suoi versi, possiamo essere certi che egli ha tratto il sapore del mondo dal sole e dal calore. Ma accade anche il contrario. Alimentato da un paesaggio uniforme, nella monotonia di un piatto orizzonte, egli cercherà la dinamica; metterà nel verso una montagna, porrà un albero trasversalmente all’orizzonte, aggiungerà al mondo qualcosa che esso non ha. Ma resterà sempre in contatto diretto con la sua patria, in questo caso – con la sua patria esterna. Nell’ambiente più prossimo, già quasi a portata non della vista ma della mano – si trovano gli oggetti di uso quotidiano, gli aspetti della vita corrente, l’intera materialità della realtà, che grazie al duro lavoro dei produttori e degli utenti si è trasformata in un valore più alto. Il poeta canta volentieri l’albero (sia esso una betulla, un tiglio o una quercia), ma meno volentieri il legno. Si sceglie piuttosto una sedia o un tavolo di legno, sceglie gli oggetti, per definirsi meglio attraverso essi.
La patria esterna del poeta è come una carta topografica della sua memoria e delle sua poesia. Con essa non si può sbagliare, ma non si può nemmeno uscire dai suoi confini senza rischio; ogni passo ulteriore può minacciare una sciagura. E tuttavia i poeti continuano a scrivere versi, versi differenti, che non ripetono le stesse vedute e gli stessi aspetti. E questi versi essi leggono, premiano, analizzano, apprezzano (oppure biasimano). Ciò è possibile solo in quanto esiste una seconda grande patria del poeta, la patria interna, protettrice dei pensieri, dei simboli, delle suggestioni, dei timori. Patria oscura e non riconoscibile. I poeti, si capisce, riescono a individuarla, ma non riescono – o non vogliono – parlare francamente di essa. Quale ninnananna li ha assopiti? Con quali immagini si è manifestata la paura delle tenebre? Di chi era la voce che sussurrava la preghiera in casa – del padre o della madre? Quali canti s’intonavano a Dio, e quali intorno al fuoco? Era più dolce l’odore delle erbe selvatiche o l’odore dei frutteti in fiore? Dove e quando cominciarono le prime iniziazioni, i primi slanci e le prime cadute? In quale luogo e in quale momento è avvenuto il passaggio dal chiaro mondo esterno all’oscuro mondo della patria interna? All’ordinato o simulato assetto, al mondo della cultura? E poi come si è mescolato tutto questo?
Davanti a simili domande i poeti fuggono furtivi, imbattendosi in un episodio del tempo della scuola o dell’università, recitando i nomi dei propri insegnanti e istruttori. Un aneddoto e un elenco di letture non spiegano nulla in poesia. Su questo sfondo abbozzato in modo approssimativo, desidero occuparmi di due poeti dei quali si può dire, generalmente parlando, che sono stati formati da identiche o assai simili patrie esterne ed interne, e ancora di più – da simili destini della vita. I risultati poetici di queste somiglianze sono tuttavia sorprendentemente diversi. Mi sia consentito di presentare brevemente questi poeti.
Eliasz Rajzman nacque a Ratno, vicino Kowel, da una povera famiglia ebrea. Sin dagli anni della prima giovinezza lavorò per guadagnarsi la vita (commercio, artigianato), e si istruì come autodidatta. Durante la guerra soggiornò in Unione Sovietica. Negli anni 1941-1943 prestò servizio nell’Armata Rossa. Dopo il ritorno in Polonia, nel 1945, si stabilì nella parte occidentale del paese, dove lavorò in una cooperativa di produzione come lavoratore dei campi. Nel 1950 si trasferì a Stettino, ove fino alla morte lavorò come artigiano. Morì nel 1975.
Pubblicò il primo libro di versi – I campi verdeggiano nel 1950. Successivamente uscirono le raccolte: Ho piantato un albero (1954), Solo con me stesso (1957), Ho sognato il sole (1961), Il linguaggio dei tuoi occhi (1967). Scrisse nella lingua yiddish. Sono apparse tre raccolte di traduzioni di sue poesie in lingua polacca: Albero autunnale (1966), Il colombo bruciato (1967), La preghiera del lupo (1979).
Arnold Słucki nacque nel 1920 a Tyszowiec, nella Polonia orientale. Nel 1934 si trasferì a Varsavia, dove terminò i suoi studi. Frequentò a quel tempo l’ambiente radicale, filocomunista dei giovani. Durante la guerra soggiornò in Unione Sovietica. Dal 1942 prestò servizio nell’Armata Rossa. Un anno dopo entrò nell’Esercito Polacco. Dopo la fine della guerra si stabilì a Varsavia, dove lavorò come redattore e giornalista. Dopo i fatti del marzo 1968 emigrò in Israele. Morì a Berlino Ovest nel novembre del 1972.
Il suo primo libro di versi – La terra risplende uscì nel 1950. Negli anni seguenti pubblicò altre raccolte poetiche, di cui le più importanti sono: Campane sulla Vistola (1958), La valle delle stranezze (1964), Egloghe e Salmodie (1966). Vanno menzionate inoltre alcune edizioni di Opere scelte, tra le quali la più interessante – Poesie scelte (1982), include anche i versi dell’emigrazione. Scrisse in polacco.
La gamma della voce poetica di Rajzman si potrebbe dire consapevolmente limitata. Tono semplice e raccolto. Espressione repressa. No, questa poesia non vuole descrivere. Essa vuole pensare. In essa il mondo visibile è suddiviso in alto e basso. Forse le immagini di questo spazio chiuso possono essere a tal punto irripetibili, che vale la pena di cercarle e studiarle? Rajzman risponde: no. L’alto è semplicemente il cielo con tutti i suoi attrezzi poetici: stelle, aurore, crepuscoli, mattini, i baldacchini delle nuvole e via dicendo. Il basso è semplicemente la terra, i sassi, la polvere, i fiori, la cenere, il fuoco, la strada e via dicendo. Non molto della patria esterna. Ma anche con quello che c’è il poeta potrebbe comporre più di un bel quadro poetico. Non vuole, perché è un lavoro troppo facile e come in contrasto con l’atteggiamento spontaneo verso l’intimità. Eppure nella sua patria interna Rajzman non cerca sostegno. Del mondo della cultura ebraica in questi versi non c’è quasi nulla. Alcuni nomi, alcune allusioni, citazioni. Poco. Molto poco. Appare chiaro che l’artista rinuncia con ostinazione e consapevolezza all’attrazione del lettore. Riduce la poesia creativa ad una materia autorisonante – se così possiamo esprimerci. Respinge tutto ciò che potrebbe impedire alla poesia di essere se stessa. Che cos’è in tal caso il “poetico essere se stesso”? E’ il più diretto colloquio dell’individuo tormentato con la memoria concreta, con l’orrore di questa memoria che non si lascia denominare né descrivere. Il poeta di fronte al suo destino assume un contegno pudico, come se temesse che un eccesso di sofferenza potrebbe diminuirla. Coerentemente quindi r e s p i n g e tutto. In una poesia constata addirittura: ”siamo giunti sulla…terra appesa al vuoto”. In un’altra scrive:
In quale posto della terra
devo posare la lapide per te
popolo mio?
Dove comincia,
dove finisce
la tua valle di pianto?
Il poeta non sa, di conseguenza egli stesso non intende trasformare i suoi versi in lapidi.
Ho visto una tale scintilla
Il mio sguardo è arso
sui sacri candelieri del sabato
e il mare non poteva spegnerla
– dice in un’altra poesia, come se una scultura nell’aria e la composizione di uno stato d’animo diventassero la sua più alta vocazione. Non è forse questo una conseguenza “dell’atteggiamento di rifiuto”? Rinunciare al sovrabbondante del mondo, agli attrezzi creatori di poesia, rinunciare perfino alla ebraicità. Lasciare soltanto il verso nudo, il verso-vento, il verso-cenere, il verso scintilla della memoria. Occorre avere un’incredibile coscienza poetica per trovarsi semiscalzi e a mani nude davanti a una così grande montagna qual è il destino dell’Ebreo, e tuttavia scalarla.
Arnold Słucki scelse un diverso atteggiamento, una posizione di a s s o r b i m e n t o. Egli sfrutta senza limitazioni l’attrezzeria della patria esterna, volentieri spolvera gli oggetti dell’ambiente circostante (un violino, un bilancino, una secchia), illustra paesaggi e vedute, canti e usanze. Baldanzosamente si aggira tra i valori della cultura ebraica e antica. In moltissimi versi troviamo i segni e i simboli della patria interna del poeta: la Valle di Josafat, i Canti della Sulamita, David, Hebron, Adamo, Eva, le Dodici Tavole, la cabala, l’arca. Il bel poemetto “Chagalliana” è come una replica poetica dei quadri di Marc Chagall. Tutto è chiaro: qui regna la sovrabbondanza. Ecco un esempio:
Ci sono ancora
le erbe di chitea, le erbe di Kanaan,
le erbe del libro di Gilgamesh,
le erbe di Sodoma e Gomorra,
che non tutti digeriscono
ma io le digerisco.
Słucki ama complicare e moltiplicare la materia dei suoi versi anche con l’impiego dei più svariati artifizi stilistici. Volentieri, ad esempio, sfrutta la stilizzazione in canzone, espone il significato di un quadro; vale la pena di citare alcuni esempi molto visivi:
le mani sotto la testa
dorme il fiume
- Le belle nuvole-cavalli dai collari scarlatti
scavano la fossa al sole
come scorre il borgo
con le lacrime sul collo
E a questa opulenza si aggiungono continuamente nuovi elementi; a volte sono tecnicismi (elicottero, radar, DNA), a volte sentimentalismi, a volte autodefinizioni, di cui il poeta ha incrostato molti versi. Essi forniscono una traccia, per cui è bene ricordarne alcuni:
Sono un vecchio Ebreo
nella polonizzata poetica miseria
- Da dove vengono questi paesaggi? –
Dal Salterio
escono
e chiedono asilo
nella mia attonita lingua polacca
Nessuno.
Un poeta senza generazione,
un fulmine fuggiasco
senza indirizzo.
Qual è dunque la traccia? E’ una traccia outsider, che vuole risultare visibile non attraverso l’indigenza, ma attraverso l’opulenza. Attraverso la sovrabbondanza. Si è perso in essa ed è come se avesse rimpiccolito il dramma dell’uomo. Suona ironico, ma è la verità. Forse non esistono limiti di forma nel legame con il contenuto? Forse con un vestito troppo elegante si può – per maggiore contrasto e per la forza dell’espressione – coprire anche un corpo malato? La patria interna in tali casi concede asilo ai poeti.
Il mondo di Rajzman riduce e respinge. Il mondo di Słucki moltiplica e assorbe. Eppure con la sua sovrabbondanza egli è un poeta assai significativo per la poesia e molto importante per la poesia polacca.
Ripetiamo la domanda: come è possibile che condizioni esterne ed interne somiglianti abbiano formato due personalità così diverse, due estetiche così diametralmente differenti? Come è possibile?
La chiave probabilmente risiede nella lingua. Słucki scriveva in polacco e nella barriera di questa lingua doveva vedere un ostacolo alla trasmissione dell’immaginazione ebraica. Ritenne probabilmente che bastasse servirsi dell’attrezzistica ambientale e culturale. Il linguaggio poetico non si può tuttavia sormontare con gli attrezzi. Neanche la lingua polacca, sempre pronta all’esagerazione poetica, sempre tendente al pensiero e all’etica attraverso l’estetizzazione. E’ un po’ una via circolare verso la destinazione. Ma nell’Europa centrale ci sono vie più difficili. E non sempre in esse si trovano tracce lasciate da poeti come Eliasz Rajzman e Arnold Słucki. Per questo li ricordo.
Marian Grześczak
Poesie di Eliasz Rajzman tradotte da Paolo Statuti
La stella
Una stella mi è caduta sulla mano,
il mondo ha parlato nella lingua stellare –
attraverso il verde e lacrime azzurre.
I pipistrelli raschiano il silenzio,
tirano la notte scura per i capelli,
i solai eseguono un canto funebre.
I neri branchi della notte strisciano,
si stringono stretti tra loro –
come attenuare l’intima oscurità?
Il cosmo si è spalancato,
il vuoto visita i suoi poderi,
dove si fermerà qui il mio pensiero?
Dove cercare il settimo cielo
qui, nel cuore della notte? –
Senza il cielo la Terra gira!…
(dalla traduzione polacca di Arnold Słucki)
Il poeta alato
Insegnami a cantare a modo tuo,
da’ spirito alla prima strofa,
il resto finirò di dirlo io,
l’alato poeta.
Hai una casa e un albero pieni di canto,
il suo succo alimenta il tuo ritmo
e il canto là sempre si anniderà,
o alato poeta.
Ma io sono andato troppo oltre
per poter udire i tuoi spensierati toni
e in me la tristezza, non il cinguettio,
poeta alato.
Insegnami a eseguire a modo tuo
il canto che si cela nelle chiome degli alberi;
verso il mondo volerà – un mondo più grande
dei miei sussurri in piatti slanci –
di alato poeta.
(dalla traduzione polacca di Piotr Michałowski)
Non sono
Non sono questo che non sono,
né quello
che voglio mettere in me.
Non cercare ciò
che io stesso non trovo
in me.
Sono un punto interrogativo
sulle strade della mia esistenza.
La grigia assurdità del mio
durare.
Il giorno e i suoi fardelli
allontano da me.
Ma io non mi rammarico del suo
calare.
Non io sono curioso
della nuova aurora.
Sotto i miei piedi c’è la terra.
Non un prato del paradiso.
Sono un domestico intruso
nel tuo sguardo,
che si posa su di me ogni notte
da un altro pianeta.
E forse?…
Mi sembra spesso
di essere ugualmente
diviso.
In società con qualcuno.
Perché è possibile
tutta la vita lottare
soltanto con me stesso?
(dalla traduzione polacca di Katarzyna Suchodolska)
Il colombo bruciato
Il colombo di carta
che un giorno mi volò via di mano,
volteggia oggi su di me
battendo le ali
e muto.
In gola
il tempo avvoltoio
soffoca la voce del colombo.
Il colombo di carta
dei miei teneri anni
mi pone sulla testa
una corona di spine.
(dalla traduzione polacca di Arnold Słucki)
L’astrologo
L’astrologo
al cielo
volge lo sguardo,
già vede
il giorno eterno
e
il sole
scorge
senza ombra.
Il sole –
esso sempre su di me,
sotto di me,
esso è in ogni
riflesso.
E che importa
se la luce lo
filtra
attraverso le dita del tempo?
Un virgulto del paradiso
germoglia
nel campo dei miei pensieri.
Chissà se i messi
di qualche nume
per esso non siano già giunti con l’ascia?
L’immagine del sogno
a lungo resterà limpida,
finché gli autunni non renderanno torbidi
i suoi occhi irreali.
L’astrologo
solleva la testa,
vede:
il sole muore
e un vecchio viandante
con la lanterna,
andando di grotta
in grotta,
cerca le ali infrante
che il tempo
ha spezzato nell’estro.
(dalla traduzione polacca di Arnold Słucki)
Poesie di Arnold Słucki tradotte da Paolo Statuti
Studio del parco
Guarda,
come a luglio,
nell’afa,
appaiono i parchi.
(Si potrebbero considerare
come onde)
Gli alberi, come mostri intrecciati scorrono
attraverso paludi di luci
e sollevate le teste dei fisici, corrugando
i turgidi colli dei tronchi,
la formula del mondo in futili fenomeni traducono.
La neve
Nevicava, tutto
coperto. Così bianco
qui;
in me sono entrate a scaldarsi le zolle
randagie,
i ruscelli, come popoli
davanti a un tribunale
mormoravano.
Chiedevo
quante lingue morte
conoscono questo mormorio.
Gli elementi
Compromesso con la pioggia,
compromesso con la neve,
compromesso con l’angelicità di nubi sospette,
con terre fumanti immobili,
sempre lungo la sponda, lungo la sponda,
compromesso nella disputa sul metodo.
Tutto questo ci salverà dal fermento degli elementi?
O Terra!
O Fuoco!
O Acqua!
* * *
Una luce nuova,
che mi
punisce,
premia,
qui
su di me
isterilendo
s’è posata,
come lacrima
su consunte
vetrate.
St. Blasien, 17 settembre 1971
A mia moglie
Contami tra i fiori,
contami tra i sospiri,
sii per me l’amata, sii per me sorella,
e quando me ne andrò –
sii madre per il mio povero nome.
Spiega alla gente, che anche se a volte
il mio canto era complicato,
l’amore in esso era semplice –
e il cuore era in esso,
cara…
(C) by Paolo Statuti
Tag:Arnold Słucki, Eliasz Rajzman, Marian Grzesczak, poesia polacca Arnold Słucki e Eliasz Rajzman tradotti da Paolo Statuti, poesia yiddish