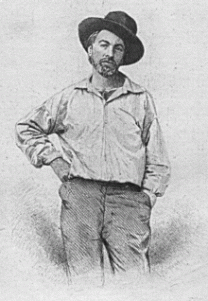Con vero piacere pubblico oggi nel mio blog questo testo di Carlo Culcasi (1883-1947), insegnante di lettere, preside, poeta e saggista, inserito nel suo libro Musica e poesia (prima edizione Istituto Editoriale Cisalpino, Varese 1936). L’autore vuole indurci a rileggere i versi del Petrarca quasi fossero una spartito, anche se non sappiamo leggere le note musicali? Proviamo, ascoltiamo le immortali strofe del Canzoniere come se uscissero da un liuto, dalla gola di un uccello canterino, da un ruscello che scroscia tra le rocce, e scopriremo che Petrarca non fu solo un grande poeta, ma anche un grande musicista della parola. Ecco uno dei miei sonetti preferiti:
Solo et pensoso i più deserti campi
vo mesurando a passi tardi e lenti,
et gli occhi porto per fuggire intenti
ove vestigio human l’arena stampi.
Altro schermo non trovo che mi scampi
dal manifesto accorger de le genti,
perché negli atti d’alegrezza spenti
di fuor si legge com’io dentro avampi:
sì ch’io mi credo ormai che monti et piagge
et fiumi et selve sappian di che tempre
sia la mia vita, ch’è celata altrui.
Ma pur sì aspre vie né sì selvagge
cercar non so ch’Amor non venga sempre
ragionando con meco, et io co’llui.
Il Petrarca e la Musica
Se Dante, poeta austero e profondo amò la musica, tanto più doveva amarla il Petrarca, per le disposizioni stesse del suo spirito, aperto a tutte le effusioni soavi, per il carattere della sua poesia così delicata e armoniosa.
Messer Francesco sortì dalla natura tutte le doti che sono necessarie a un musico: ebbe un senso squisito dell’armonia e del ritmo, ebbe dolce e canora la voce, possedette, insomma, il genio della musica.
Il Boccaccio, che gli fu amico e lo conobbe da vicino, scrisse che il Petrarca: «In musicalibus vero, prout in fidicinis et cantilenis, et nondum hominum, sed etiam avium, delectatus ita ut ipsemet se bene gerat et gesserat in utrisque».
Filippo Villani, che gli fu contemporaneo e ne scrisse la vita in latino, così parla di lui: «Petrarcha doctus insuper lyra mire cecinit, unde labores studii modeste levabat… Fuit vocis sonorae atque reduntantis, soavitatis tantae atque dulcedinis, ut nescirent etiam doctissimi ab eius collocutione discedere».
Oltre a questi, parecchi altri biografi, tutti contemporanei o di poco posteriori al Petrarca, concordano nel dire che egli si dilettava moltissimo di musica, e che aveva una singolare attitudine e disposizione per le cose musicali.
Che poi il Petrarca possedesse qualche strumento, si ricava con certezza da una notizia che ci dà egli stesso nel suo testamento, dove lasciò scritto: «A maestro Tomaso Bambasio lego il più buono dei miei liuti, onde si valga suonandolo non ad usi profani, ma in lode di Dio».
E se possedeva parecchi liuti, se aveva una bella voce, e suonava e cantava, non può dubitarsi che conoscesse anche la musica.
* * *
Il Petrarca cantò per tutta la vita; chè il suo lungo esercizio poetico può considerarsi come un canto continuo, ispirato e soavissimo. Se non si fosse tanto dilettato di musica, di armonie di corde e di liuti, egli non sarebbe stato il poeta che fu. Egli trasfuse nel Canzoniere tutto il suo entusiasmo per la musica, e fece sì che la poesia fosse materia di suoni e d’accordi, di numeri e di cadenze musicali. Nella sapiente architettura delle strofe, nell’accorto uso della lingua, nella scelta delle parole, nella stessa disposizione delle sillabe nel verso, egli si palesò, più che poeta, musicista di rarissimo talento.
Egli, grazie al suo squisito sentimento dell’armonia e del ritmo, non solo perfezionò lo strumento della lingua, liberandola d’ogni suono duro e aritmico, d’ogni scoria arcaica e plebea, raffinandola e nobilitandola, ma la rese anche snella, flessuosa, trasparente, come una musica viva e pulsante, rispondente ad ogni voce interna, ad ogni moto dell’anima.
Il Petrarca diede molta importanza all’elemento musicale che è insito nelle parole, e fece sì che esse esprimessero, per la virtù stessa del suono, molto più di quanto significano nel linguaggio ordinario e comune. Infatti, nella melodia strofica del Canzoniere, le parole son così disposte che acquistano spesso una individualità tutta nuova ed assumono una significazione che, se è vaga ed imprecisa, desta una infinità di echi maliosi e suggestivi, indefinibilmente dolci e soavi, che sembrano quasi imitare le voci e i suoni della natura: il canto degli uccelli, il mormorio delle acque, il sussurro delle fronde. Il Petrarca ci fa sentire più di quanto dice, ci desta delle sensazioni nuove e imprevedute che non sappiamo spiegarci e sono dovute a una parola, ad un verso, ad una semplice successione di vocali e di consonanti, le quali, così disposte, assumono un valore più alto, e prendono una significazione nuova, che trascende quella abituale, e ci commuove e suggestiona, e non sappiamo come, e non sappiamo perché.
L’acquisto di questa forma, così bella e varia, così perspicua e melodiosa, costò molto al Petrarca. La politezza del Canzoniere è dovuta ad un lungo lavorìo di pazienza e di amore, di cui ci danno testimonianza sicura le numerose postille che il sapiente artefice appose nei suoi manoscritti. Egli lavorava, come si dice, di cesello, con cura minuziosa e sottile, faceva e rifaceva i suoi versi parecchie volte, leggendoli ad alta voce, cantandoli a suon di liuto, fin quando avesse raggiunto quella perfezione che il suo fine senso estetico gli additava. In fine, contento, scriveva la formula sacramentale: Hoc placet.
E in questo suo Canzoniere, così martellato e tormentato, quanta ricchezza di lingua, quanta fluidità ed armonia, quale abbondanza di rime, di assonanze, di allitterazioni! Il musicista vi si appalesa ad ogni passo: certe canzoni son così bene armonizzate nelle varie parti, che fan pensare, più che a un componimento poetico, ad una sinfonia dalle linee belle e grandiose. Parecchi sonetti hanno, direi quasi, un’andatura musicale, c’è in essi qualcosa per cui somigliano ad una sonata piccola e dolce, dotata di uno straordinario potere suggestivo. In alcuni sonetti c’è quasi lo spunto d’una melodia, d’una romanza soave e melanconica, che potrebbe essere di un Marcello o di un Pergolesi. In alcuni altri, in quelli per esempio che incominciano: Io canterei d’amor sì nuovamente – Se amor non è, che dunque è quel che sento, vi è una così sapiente disposizione di rime in ale e in ento, in ente e in ivi, da far pensare ad una arietta metastasiana, musicata da un mellifluo maestro del settecento.
Non per nulla i poeti che vennero dopo, quelli specialmente più dolci e musicali, dal Poliziano al Metastasio, tennero sempre gli occhi rivolti al Petrarca, considerandolo come il vero e l’unico modello da imitare, come l’artista impareggiabile, che aveva creato il più soave eloquio della poesia, e aveva fatto del patrio volgare la lingua più melodiosa e musicale del mondo.
Carlo Culcasi